racconto
by Salvatore Barone*, Italy, exclusive for The diagonales
[google-translator]
Con l’arrivo di maggio Telemaco perdeva la voglia di andare a scuola. La fine dell’anno scolastico si avvicinava, il mare mandava per le strade della città i suoi profumi e i suoi allettanti, eppur misteriosi, inviti e il ragazzo si persuadeva che durante l’anno scolastico s’era impegnato molto. Pertanto, un giorno decise che avrebbe marinato la scuola.
Il padre, marinaio di lungo corso, si era imbarcato da poco e sarebbe passato molto tempo prima del suo ritorno. Si ricordò del vecchio professor Socrate De Montis che non vedeva da un po’ di tempo. Lo aveva conosciuto l’estate passata, in riva al mare, mentre, seduto su uno scoglio, era intento a guardare l’orizzonte. Da quella volta lo aveva rivisto quasi tutti i giorni nel restante periodo delle belle giornate; più di rado in inverno. Chissà, forse lo avrebbe ritrovato a passeggiare lungo il litorale. Decise così di indirizzare i suoi passi verso la scogliera che da Catania prosegue verso Aci Castello.
Il professore era un tipo solitario, dai grandi occhi indagatori e infossati, per via delle troppe sigarette che aveva fumato nella sua vita. Quando ti guardava sembrava che volesse chiederti qualcosa d’importante e le sue parole, ogni volta, ti davano un barlume di luce su quello che i suoi occhi vedevano. A Telemaco piaceva parlare con lui.
Non dovette camminare molto prima di trovarlo. Come spesso accadeva, forse a causa dell’età, era seduto su uno scoglio, dolcemente lambito dalle onde. Il ragazzo gli si avvicinò senza far rumore per non disturbarlo e non lo salutò. Il professor De Montis, però, lo aveva sentito arrivare. Fu lui, infatti, a rivolgergli la parola:
- Telemaco, è da un po’ che non ci vediamo.
- La scuola! Mi ha impegnato troppo.
- Lo studio non impegna mai troppo.
- Sì, però ci sono tanti modi per imparare.
- Hai ragione!
Rimasero in silenzio finché fu di nuovo il vecchio professore a parlare per primo e a chiedere:
- Di cosa vuoi che parliamo?
Telemaco rifletté un po’. Poi, di botto, esclamò:
- Del nostro dialetto!
- Ah! L’argomento è interessante. Ma come potremmo discorrerne? Fammi pensare.
Anche il professore si diede qualche istante di pausa. Infine esordì così:
- Cercherò di interpretare per te alcune parole ed espressioni del nostro dialetto. Stammi ad ascoltare, e dimmi cosa ne pensi. Voglio cominciare con “cattivu”. Conosci questa parola?
- E’ la persona cattiva, che fa cose con cattiveria.
- Anche. Ma nel nostro dialetto “u cattivu” o “a cattiva” designano pure lo sposo o la sposa ai quali sono morti la moglie o il marito. Essi potrebbero risposarsi, ma, chissà per quali condizionamenti sociali o motivi personali, decidono di non farlo. Possono rimanere in questo stato civile per molti anni e in alcuni casi per tutta la vita. Le situazioni sono differenziate e riflettono ognuna particolari eventi o cause che le hanno provocate. Ora, non credo che può interessarci fare qui una casistica, ma riflettere sulla parola che definisce nel nostro dialetto lo stato di vedovo e, se ciò non appare azzardato, individuare alcune motivazioni del suo comportamento. Cattivo, cattiva…. Risalta subito l’identica denotazione della parola con l’aggettivo della lingua italiana. Cambia, però, il significato. In italiano, secondo la definizione che ne dà il dizionario, il cattivo è colui che è contrario ai modelli e ai principi morali correnti. È un essere riprovevole, malvagio agli occhi dei più. Come vedi, sarebbe avventato e ingiusto stabilire una stretta comparazione tra il significato della parola nella lingua italiana e il suo significato nel dialetto siciliano. Però è strano che nel nostro dialetto per designare la condizione del vedovo o della vedova si ricorra a un aggettivo così fortemente connotato nella lingua italiana; una parola che, fra l’altro, nel siciliano diventa un sostantivo. Ho riflettuto spesso su queste stranezze e mi sono chiesto se il chiamare “cattivu” il vedovo non abbia a che fare con lo stato di cattività, una sorta di prigionia morale in cui i nostri vedovi e, ancor più, le nostre vedove si rinchiudevano o venivano rinchiusi per rispettare la memoria delle spose e degli sposi defunti. Da questa condizione di “cattività” poteva emergere uno stato di frustrazione non facilmente contenibile che, a sua volta, poteva veramente “incattivire” gli animi di questi sventurati.
- Tutto qui?
- Ti sembra poco?
Il ragazzo non rispose. Voleva continuare ad ascoltare e così invitò il professore a riprendere le sue considerazioni sulle parole dialettali. Il professor De Montis gli rivolse un sorriso e gli chiese:
- Hai mai sentito il verbo “ciuciuliari”?
- Qualche volta?
- Il “ciuciuliari”, come forse dunque saprai, è un particolare modo di parlare. Due o più persone che “ciuciulianu” intendono far vedere a una o più persone che li osservano che si sta parlando di qualcosa che li riguarda. Ma chi “ciuciulia” non vuole far sentire nulla di chiaro, solo il “ciuciuliari” che è un insieme di suoni, una perversa melodia, una specie di fastidioso canto di uccelli, l’inizio del dubbio e del sospetto in chi si sente oggetto del “ciuciuliu”. Si vuole creare un clima di sospensione, di incertezza perché chi “ciuciulia” non è interessato a chiarire i fatti, ma solo ad infondere il dubbio.
- Non c’è comunicazione, – osservò Telemaco.
- Hai detto bene. Ti dirò di più: non si vuole comunicare veramente.

Osservarono qualche istante di silenzio, poi fu lo stesso professor De Montis a riprendere:
- Già che ci siamo, a proposito dei luoghi della comunicazione ti dirò del “curtigghiu”. Forse qualche volta hai sentito anche questa parola.
- Sì, qualche volta.
- Ebbene, “u curtigghiu” era il luogo fisico della comunicazione sociale e i “curtigghiari” erano i suoi frequentatori. Tipico spazio dell’architettura urbana del meridione ai tempi della civiltà contadina, “u curtigghiu” era il luogo, in genere chiuso in tre lati dalle mura delle case, dove i viciniori si riunivano per attendere ai lavori domestici, per parlare e qualche volta per “ciuciuliari”. Nelle belle giornate, solitamente erano le donne a darsi tacito ed abituale appuntamento nei “curtigghi”. Ma non si parlava soltanto. Mentre gli uomini erano a lavorare in campagna, le donne finiti i lavori di casa, vi si riunivano anche per adempiere a lavori di cucito, di ricamo o a lavori di trasformazione dei prodotti agricoli. Era, quindi, sia il luogo del tempo libero, quando ancora questa nozione sociologica non esisteva, sia il luogo dove le donne aiutavano i loro uomini a rendere commestibili i prodotti della Terra. Ad esempio, mescolare l’estratto di pomodori sotto il sole cocente, togliere il mallo alle noci, una volta fatte essiccare, sgusciare a colpi di pietra le mandorle dure, eccetera. La meccanizzazione della vita sociale e adesso l’elettrificazione e l’informatizzazione delle relazioni umane hanno reso più difficile, se non impossibile, la riunione in questi luoghi, perlopiù usati per il posteggio degli autoveicoli. Quando “u curtigghiu” era il luogo della comunicazione sociale il contadino vi arrivava con il proprio asino, mulo o cavallo ed erano questi animali che egli legava alla “vuccula”. Ma l’asino, il mulo e il cavallo addomesticato erano animali discreti e non valevano certo le decine di “cavalli” dei mezzi di trasporto odierni, rombanti inquinanti e oltremodo rumorosi.
- E la “vuccula”, cos’era?
- Era un ferro battuto, di forma tondeggiante, attaccato al muro esterno delle case. Vi veniva allacciata la corda con la quale si conduceva l’animale.
I due furono distratti da alcuni pesci che s’erano avvicinati agli scogli e che sembravano in combutta tra di loro. Qualcosa galleggiava a filo d’acqua e irrimediabilmente il più grosso di loro riuscì a farne un boccone.
- “Musta ‘cca!”. Hai mai sentito questa espressione?
- No, mai!
- Letteralmente vuol dire “Dammi qua!”. È un imperativo categorico? No! Questa espressione non ha nulla a che vedere con la morale kantiana. Nel filosofo l’imperativo categorico era una ingiunzione che l’io faceva a sé stesso per indirizzare la propria azione verso il raggiungimento di fini ritenuti giusti. “Musta ‘cca!” esprime, invece, un rapporto fra almeno due individui ed ha per oggetto il possesso di un qualche bene tangibile.
 “Musta ‘cca!” ha il sapore dell’estorsione che un prepotente opera nei confronti di una persona più debole; è un residuo del linguaggio feudale e della sua concezione dell’organizzazione sociale. Il fatto che fino a qualche tempo fa si sia mantenuta come espressione nella lingua del siciliano, trova il suo corrispondente oggettivo nella pratica mafiosa. Potremmo, anzi, indicare “Musta ‘cca!” come il segno linguistico di questa pratica e la scomparsa progressiva del suo uso come il segnale di una mentalità o cultura che il popolo siciliano non vuole più riconoscere.
“Musta ‘cca!” ha il sapore dell’estorsione che un prepotente opera nei confronti di una persona più debole; è un residuo del linguaggio feudale e della sua concezione dell’organizzazione sociale. Il fatto che fino a qualche tempo fa si sia mantenuta come espressione nella lingua del siciliano, trova il suo corrispondente oggettivo nella pratica mafiosa. Potremmo, anzi, indicare “Musta ‘cca!” come il segno linguistico di questa pratica e la scomparsa progressiva del suo uso come il segnale di una mentalità o cultura che il popolo siciliano non vuole più riconoscere.
Il professor De Montis si fermò all’improvviso e fu chiaro a Telemaco che aveva avuto un ripensamento.
- No! È probabile che il “Musta ‘cca” non riguardi solo la mentalità mafiosa, ma ogni prepotenza che un singolo o un’organizzazione sociale fanno nei confronti dei più deboli.
Ci furono lunghi momenti di silenzio e nel frattempo rivolsero i loro occhi verso il mare, verso il suo orizzonte lontano, sgombro di ogni presenza umana. Solo alcuni gabbiani volavano in prossimità della riva o s’appoggiavano per brevi momenti sull’acqua facendosi trasportare dalle correnti. Infine il professor De Montis riprese a comunicare a Telemaco i suoi pensieri.
- Ti voglio adesso parlare di un’altra espressione, ben diversa da quella di prima: “Fai u saggiu”. Questa sì che l’hai sentita qualche volta.
- Qualche volta.
- In italiano “u saggiu” è il saggio, l’uomo adulto, molto spesso in età avanzata, che dà segni evidenti di equilibrio e di assennatezza. Nel nostro dialetto il termine viene usato nelle tipiche espressioni imperative “Fai u saggiu!”, “Stai saggiu!”, “Diventa saggiu!” che gli adulti rivolgono a bambini e ragazzini particolarmente vivaci quando ne combinano una delle loro. È un invito contingente o un consiglio per la vita? Mi piace propendere per questa seconda interpretazione, anche se ritengo che simili esortazioni risultino di difficile realizzazione per dei ragazzi. Confronta, ad esempio, “Fai u saggiu!” con la corrispondente esortazione in lingua italiana “Fai il buono!”. C’è una bella differenza tra le due. Fare il buono è impresa incommensurabilmente più facile per un bambino piuttosto che fare il “saggio”. Anche perché nei momenti d’intimità tra l’esortante, in genere un parente stretto, e l’esortato, il bambino, l’invito “Fai u saggiu!” si trasforma in “Diventa saggiu!”. Se allora prendiamo in considerazione queste due ultime espressioni, risulta più evidente il carattere di impegno per la vita al quale il bambino è chiamato. Ma può un bambino fare “il saggio”? Non è probabile che ci preoccupiamo della saggezza dei bambini in considerazione della nostra stoltezza, così sperando che loro possano fare meglio di noi?
Il sole s’avvicinava allo zenit e Telemaco pensò che era arrivato il momento di tornare a casa. Il professor Socrate De Montis pensò la stessa cosa.
- Andrai a casa adesso?
- Sì!
I due si salutarono e mentre il ragazzo si dirigeva verso le case della città non si chiese se quel giorno era stato un giorno importante per lui, ma pensò che il linguaggio era quanto di più straordinario gli uomini avessero mai inventato per ricreare la realtà nella quale viviamo.

*Salvatore Barone vive a Licodia Eubea, provincia di Catania, Sicilia. Si è occupato di cinema e in particolare della nouvelle vague francese. Ha soggiornato in varie città tra cui Londra, Parigi, Zurigo e Roma. Tra le sue opere vi sono raccolte di poesie (Movimenti liberi, 1988), storielle (Demetra ascolta, 1999). E’ autore della trilogia di romanzi brevi Pierrot lunaire, Fraulein Folgheraiten, In una conca di luce pienamente solare. Il suo ultimo lavoro è Càliti juncu, proverbi e detti siciliani meditati.


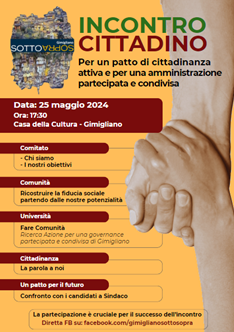




Devi effettuare l'accesso per postare un commento.